
 Da
sinistra: Andrea Pozzo, Trionfo di sant’Ignazio di Loyola, 1691-94,
chiesa di Sant’Ignazio, Roma; Baciccio (G. B. Gaulli), Trionfo del nome del
Gesù, 1676-79, chiesa del Gesù, Roma.
Da
sinistra: Andrea Pozzo, Trionfo di sant’Ignazio di Loyola, 1691-94,
chiesa di Sant’Ignazio, Roma; Baciccio (G. B. Gaulli), Trionfo del nome del
Gesù, 1676-79, chiesa del Gesù, Roma.Postmoderno
Come
definire la nostra epoca e la nostra cultura? Le definizioni che vengono
proposte variano enormemente a
seconda che ci si riferisca alla società umana nel suo insieme, alla cultura,
alla scienza o alle arti in maniera specifica.
Come
ci vogliamo denominare un punto di vista epocale? Le denominazioni epocali del
passato sono state pressoché sempre scandite dalla variazione degli stili
artistico-architettonici: egizio, classico, greco-romano, bizantino, romanico,
gotico, rinascimentale, manieristico, barocco, neo-classico, romantico, moderno
… Tutte queste definizioni, anche se non sempre formulate contemporaneamente
agli eventi, sono state maturate all’interno di gruppi sociali particolari,
adibiti alla produzione di merci di carattere leggero, predisposti ad attribuire
i nomi alle cose e non coinvolti direttamente nel progresso del mondo
tecnologico. Non s’è mai sentito, infatti, che un periodo venisse denominato
per merito di un’invenzione tecnologica o economica, per quanto rivoluzionaria
essa possa essere stata: la staffa, il giogo spallare, la moneta cartacea, il
mulino ad acqua, la cambiale, la stampa a caratteri mobili, la telefonia, il
velivolo aereo … A queste fondamentali scoperte, che hanno cambiato
radicalmente la società, contrassegnandone i caratteri fondamentali per lunghi
periodi, non si è dato alcun credito rispetto alle derivate di carattere
artistico-architettonico.
Per
la prima volta, oggi, assistiamo all’impossibilità di sopravvivenza di
qualsiasi forma di “grande stile” e più probabilmente proprio alla morte di
ogni stile. Nello stesso tempo constatiamo un enorme diffondersi di novità
scientifiche e tecnologiche, sociali, politiche, economiche e
"culturali" talmente originali ed inedite da non trovare terreno di
confronto e di similitudine con nulla di ciò che è avvenuto nel passato.
La
collocazione dell'arte accanto a queste nuove realtà è rovesciata, nel senso
che è essa in qualche misura a dipendere dai grandi rivolgimenti operati dalla
cultura tecnologica e scientifica e non più viceversa.
Qualsiasi
definizione si voglia comunque dare alla nostra epoca, essa non potrà non tener
conto dell’insieme di contraddizioni sempre più forti di carattere sociale
ed economico, che si sono venute accentuando negli ultimi decenni su tutto il
pianeta e le cui ferite sono difficilmente risanabili: il divario tra paesi
ricchi e paesi poveri, la disparità demografica tra nord e sud, la contrapposizione
religiosa e culturale tra i vari pensieri integralisti, la crisi di valori nel
comportamento sociale dell’occidente, l'aumento dei consumi e degli sprechi
e l'impoverimento delle scorte naturali, lo scontro tra tendenze globalizzanti,
tensioni patriottiche ricerca di un’identità culturale, l'incrociarsi
dell’organizzazione elettronica del pianeta con il nomadismo umano di sopravvivenza,
la schisi sempre più profonda tra livello delle ricerche scientifiche e
utilizzazione possibile di tali risultati per la società nel suo complesso.
Ciò
che sconvolge il nostro pensiero “critico” è constatare che tutto ciò che
abbiamo qui delineato, e che configura una realtà da incubo, è perfettamente
noto, perfettamente visibile: la comunicazione
visiva di questi fenomeni è globale e vanamente nota.
Tra
tutte le definizioni che sono state proposte e discusse, quella che maggiormente
sintetizza, almeno per quanto riguarda l’occidente, questo insieme di tensioni
impacificabili e questo nodo di eventi, che non possiamo o, piuttosto non vogliamo
più spiegare mediante un’analisi razionale e unitaria - è “postmodernità”.
Il
termine, di cui spiegheremo più dettagliatamente il significato, va sin d’ora
chiarito nelle sue linee generali: è un termine che vuol intendere una diversità
e una lontananza relativa, ma inconfutabile, della condizione culturale attuale
rispetto alle caratteristiche di quella che era stata la cultura “moderna”,
quella cultura che, nata con il rinascimento quattro e cinquecentesco,
rafforzata dal passaggio attraverso il “contestativo” pensiero illuminista
del Settecento, giunge alla rivoluzione industriale dell’Ottocento per
approdare, infine, al razionalismo critico, alla scienza e alla tecnologia del
Novecento.
Il
carattere della nostra cultura "occidentale" – precisazione
politico-geografica necessaria, dal
momento che stiamo parlando di una sola parte del mondo - sarebbe determinato,
secondo Fredric Jameson,
dalla sparizione di tutti modelli di profondità che avevano
dominato l’epoca moderna (Jameson è stato uno degli analizzatori più acuti
del postmoderno; Il postmoderno o la
logica culturale del tardo capitalismo, 1984).
Premettiamo
subito un’osservazione: il carattere “negativo” più evidente della
postmodernità consisterebbe, dunque, nella mancanza di “critica” razionale
degli eventi (di qualsiasi natura essi possano essere), non più contrapposti
tra loro e selezionati in funzione di un forte senso della misura e
dell’etica, ma confusi e intrecciati tra loro: una
cultura di citazione, priva di stile e di razionalità autonoma, dominata
dall’effetto di decorazione e di superficie
(Omar Calabrese).
Il
barocco
A
causa di queste specifiche caratteristiche alcuni studiosi hanno definito la
nostra epoca, alla fine della modernità, come un’epoca assai simile a quella
barocca, sviluppatasi nel Seicento, in cui si assiste
all’intreccio continuo tra reale e immaginario, tra verità e finzione,
tra naturale e artificio.
Nella
produzione delle sue macchine visionarie, il Barocco non sente l'esigenza di
chiarire i debiti di carattere formale o contenutistico delle sue opere con il
passato o con gli stessi contemporanei; esso macina tutto ciò che vede per
produrre una super-visione senza confini e senza rispetto per l’originale,
l’identità, la singolarità.
Il
cinismo post-moderno è, in questo senso, molto vicino all'arroganza barocca. Il
gioco crudele, a cui ricorre la pratica neo-barocca dell'arte o
dell’architettura (si pensi alla “ricostruzione” di architetture famose
nei parchi a tema, per esempio), è quello di rendere indistinguibile ciò che
è vero da ciò che è falso.
La
realtà e l’artificio, come si sa, vengono dalla cultura barocca resi contigui
e interdipendenti: basta visitare, e l’esempio è d’obbligo, una chiesa
barocca, per accorgersi di tutti gli innumerevoli giochi illusivi che ne
caratterizzano la spazio, la decorazione e la stessa struttura: fregi dipinti
che sembrano stucchi, stucchi che sembrano strutture edilizie, spazi che
sembrano veri, architetture effimere, che sembrano eterne …, cupole che
sembrano cieli.

 Da
sinistra: Andrea Pozzo, Trionfo di sant’Ignazio di Loyola, 1691-94,
chiesa di Sant’Ignazio, Roma; Baciccio (G. B. Gaulli), Trionfo del nome del
Gesù, 1676-79, chiesa del Gesù, Roma.
Da
sinistra: Andrea Pozzo, Trionfo di sant’Ignazio di Loyola, 1691-94,
chiesa di Sant’Ignazio, Roma; Baciccio (G. B. Gaulli), Trionfo del nome del
Gesù, 1676-79, chiesa del Gesù, Roma.
Calabrese
(L'età neobarocca, 1987) ricorda, in
modo particolare, due opere che meglio di qualsiasi altre possono essere prese
in considerazione come esempi precipui della tendenza fondamentale del
neo-barocco, la citazione: il celebre romanzo di Umberto Eco
Il nome della rosa, e l’altrettanto famoso film di Steven Spielberg
I predatori dell'arca perduta.
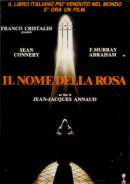
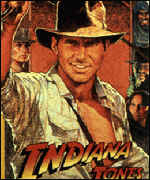
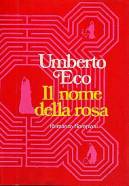
Un
libro e un film che, a detta degli stessi autori, sono degli "ammassi di
citazioni"; Eco dichiara, con
acuta provocazione, di non esserci una parola di suo nell'intero romanzo, e
Spielberg tiene a precisare il numero delle citazioni cinematografiche
presenti nel suo film: circa 350!
Ovviamente,
c'è citazione e citazione, e Calabrese, molto opportunamente, opera delle
distinzioni ... di classe! Personalmente ritengo che la citazione sia un
parametro straordinario per distinguere la "classe" dell'autore
(citare, difficile è!), ma anche per comprendere la differenza tra tendenza
manieristica e tendenza barocca, ambedue citazionistiche, con fondamentali
differenze.
Nel
Manierismo la citazione si inscrive all'interno di un'opera originale, nella
quale si vuole consapevolmente fare omaggio, in una sua parte, ad un altro
autore; nel Barocco, la citazione acquista un livello totalizzante e illusorio,
nel quale risulta difficile distinguere i territori, i materiali, i riferimenti.
Il Manierismo riflette la messa in crisi delle certezze, connesse con la
visione classicistica del Rinascimento, il Barocco persegue una ricerca di
totale deflagrazione dei generi e dei confini, e, per fare ciò, non guarda
troppo per il sottile.
Mario
Perniola, che già si era occupato, tra gli altri argomenti di critica estetica,
di analisi del contemporaneo (La società
dei simulacri, 1983), in un libro intitolato Enigmi.
Il momento egizio nella società e nell'arte (1990) afferma che lo stato
attuale della cultura è caratterizzato da una sorta di "effetto
egizio", nel senso che, come era stato tipico della civiltà egizia, anche
la nostra sembra possedere la tendenza ad
annullare in un'unica dimensione temporale l'antico e il nuovo, ponendoli
l'uno accanto all'altro e lasciando aperta la contraddizione che ne deriva.
L'esempio,
che Perniola adduce per dimostrare la sua tesi, è proprio quello della tecnologia
televisiva, che ci permette di attualizzare, vale a dire di rendere presente,
tutto ciò che appartiene a tempi diversi; la compresenza, nella comunicazione
televisiva, di eventi passati con fatti presenti induce ad una perdita del senso
delle distanze temporali: il presente
è diventato un passato che ritorna subito, e il passato un presente potenziale
che può essere reso attuale in qualsiasi momento. Anche i "tempi"
sono sottoposti al principio vigente dell'interscambiabilità dei valori,
presente passato e futuro giocati come figure marginali sulla scena attuale.
Perniola
insiste particolarmente sul carattere definitivamente permutatorio della
nostra epoca, per cui tradizionali categorie dialettiche, come alto/basso,
maschile/femminile, luminoso/tenebroso, vita/morte, organico/inorganico,
sembrano essere avviate ad un mostruoso intreccio combinatorio.
Prima
di affrontare la definizione e i caratteri del postmoderno, dobbiamo indugiare a
capire al questione neo-barocca, che ne è un fondamento.
Dobbiamo
risalire al grande pensatore tedesco Walter Benjamin, il quale, nella sua opera Il
dramma barocco tedesco, del 1928, aveva già intuito il diffondersi di un
sentimento mondano, un sentimento sociale e individuale privo di profondità e
di tensione metafisica e implicato nella ricerca estetica di un formalismo
soltanto esteriore.
Non
a caso Benjamin vedeva il fenomeno culturale barocco come un’anticipazione del
suo tempo, in quanto ambedue caratterizzati da una parallela e indomabile
pulsione a trasformare la realtà
in invenzione e in spettacolo continuo.
Deformazione
di funzioni, di materiali, di sostanze, di sentimenti.
Un'invenzione,
quella barocca, di tale portata da sconvolgere non solo gli aspetti formali
delle opere d'arte, ma l'intera concezione del vedere e del rappresentare.
L’aperto
e il chiuso, l’esterno e l’interno, l’esteriorità e l’interiorità, il
corpo e lo spirito, giungono a convivere misteriosamente dentro una piega
che ne dà forma continua!
Barocco,
dunque, come unica rappresentazione coerente dello squilibrio, riflesso
strutturale di un desiderio che non può raggiungere il suo oggetto:
desiderio per cui il logos non ha collocato altro che uno schermo, che nasconde
la sua carenza. Come sostiene Perniola, il neo-barocco contemporaneo è la
messa in forma del dinamismo stesso di questo disequilibrio tra interiorità ed
esteriorità, con una netta predominanza dell'effetto esteriore su quello
interiore, l'arte trasformatasi in quello che può essere definito come un solenne
dispositivo, una macchina di produzione spettacolare di tipo
organizzativo.
Di
fondamentale importanza per la comprensione del fenomeno neo-barocco sono
alcuni lavori di Baudrillard, in modo particolare quelli dedicati allo studio
dei simulacri e dei cosiddetti "scambi simbolici". Nel saggio di
postfazione a Simulacri e impostura
(1977 -1980)
e intitolato Noialtri barocchi e
Baudrillard, del 1979, Furio Di Paola sottolinea l'importanza estrema di
questo maitre à penser francese
nell'analisi, di derivazione benjaminiana, delle connessioni tra tecnica e
simulacro, e soprattutto
nell'elaborazione delle riflessioni sul barocco come dimensione e categoria
fondamentale della simulazione, vero e proprio "universo cool",
in cui l'unica apparenza di calore è ingannevolmente offerta dalle pratiche
persuasive della seduzione. Proprio questa riabilitazione delle strategie
seduttive caratterizzerebbe quello che Guy Scarpitta, in L'artificio,
del 1988, decisamente chiama il ritorno
del barocco.
La
piega
Tale
ritorno al barocco sarebbe documentato dalle seguenti ricorrenze: l'arte della
massima eterogeneità; la proliferazione dell'ornamento; la "mostruosità"
formale; l'imporsi di un'arte della carne; l'arte della seduzione; il movimento
febbrile, insieme angoscioso ed estatico; la trasversalità di una retorica
generalizzata; l'iper-teatralizzazione.
Scarpitta
parla di ondate di stucco, generate da un'esplosione, che ha lasciato un centro
vuoto.
Deleuze,
nel suo libro sulla Piega, anch'esso
dell'88, osserva: Il barocco inventa
l'opera o l'operazione infinite. Il problema non è come finire una piega, ma
come continuarla, farle attraversare il soffitto, portarla all'infinito. (...)
La piega infinita separa o passa fra la materia e l'anima, la facciata e la
stanza chiusa, l'esterno e l'interno. La linea d'inflessione è una virtualità
che non smette di differenziarsi
(p. 53).
La
piega infinita separa o passa fra la materia e l'anima, la facciata e la stanza
chiusa, l'esterno e l'interno. La linea d'inflessione è una virtualità che
non smette di differenziarsi: si attualizza nell'anima, ma si realizza nella
materia:
da ciò la doppia figura del contrasto, che è solo apparente, tra luce e ombra,
tra bene e male. Da ciò il fascino del contrario. L'estasi delle sante
berniniane, Teresa (1647-52) o Ludovica Albertoni (1671-74), rappresenta il
punto segreto e misterioso della piega che fa reclinare sullo stesso corpo e
nello stesso momento gli estremi del piacere e della morte. Della morte per
piacere e del piacere della morte.


Il
postmoderno potrebbe essere, dunque, simbolicamente rappresentato dalla figura
della piega, perché in essa prende forma la contiguità tra materia e
vuoto, tra luce e ombra, tra peccato e redenzione, tra cinismo e commozione, tra
verità e ipocrisia, tra realtà e artificio, che sono tutti fenomeni assimilati
dalle regole dello spettacolo, con cui il sociale, il politico e lo stesso
religioso vengono parimenti governati.
La
definizione deleuziana dell'arte contemporanea è “ripiegamento portato
all'infinito”: il fatto è che la piega
non simula soltanto tutte le materie, che diventano anche materie di espressione,
seguendo scale, velocità e vettori differenti (le montagne e le acque, le
carte e le stoffe, i tessuti viventi, il cervello), ma determina e fa apparire
la forma, ne fa una forma d'espressione, Gestaltung, l'elemento genetico
o la linea infinita d'inflessione, la curva a variabile unica.
Severo
Sarduy, nel suo lavoro sul "barroco", (Barroco,1975),
pone
con molta decisione la questione dell'attualità del barocco, la cui funzione
consisterebbe nel dilapidare il
linguaggio in funzione unicamente del piacere, e non, come vuole l'uso
domestico, in funzione dell'informazione.
Ad
Omar Calabrese, e particolarmente al suo libro L'età
neobarocca, che risale al 1987, e dunque precedente di un anno all'uscita
dei contributi di Deleuze e degli altri autori già indicati, va il merito di
avere affrontato molto acutamente la questione del neo-barocco contemporaneo e
di averne lanciato definitivamente la definizione attuale; Mille
di questi anni (1991) e soprattutto Caos e bellezza. Immagini del
neobarocco (1991) approfondiranno
ulteriormente la tematica.
Postmoderno
Come
dice la parola, il termine “post-modernità” o “postmoderno” fa
riferimento alla modernità, indicando il suo superamento: un superamento,
ovviamente, non solo di carattere temporale, ma soprattutto di tipo culturale.
Il
concetto di “posteriore” lo ritroviamo in un contesto particolare di
denominazioni storico-politiche, come, per esempio, in “post-industriale”,
“post-marxismo”, “post-comunismo”.
Nel
termine “postmoderno”, il concetto di posteriorità possiede un significato
fondamentalmente contrappositivo: il moderno è sentito come definitivamente
superato. Prima di proseguire è opportuno subito chiarire che non tutti gli
studiosi, che pur accettano questa
definizione, concepiscono il postmoderno come un fenomeno culturale con
caratteristiche completamente opposte a quelle possedute dalla
modernità, ritenendo che esso ne sia, per così dire, una sorta di
derivazione evolutiva, e, quindi, continuando a possederne dei caratteri tipici.
Se
un eccesso di senso dominava il mondo della modernità, e la crisi
del linguaggio consisteva nell’estrema difficoltà di dire fino in
fondo la profondità del “senso del mondo”, la post-modernità è
caratterizzata dalla constatazione che il mondo ha perso definitivamente ogni
suo senso e che la realtà residuale appartiene solo a quel sistema di
linguaggio che ne parla.
È
proprio nell’epoca delle avanguardie storiche, con la disintegrazione
linguistica e formale dell’arte, la fine della rappresentazione e l’inizio
del “montaggio” casuale dei frammenti residuali di senso, che ha avuto luogo
la perdita tragicamente definitiva di quelle sicurezze, che avevano costituito
il carattere forte della razionalità occidentale: anzi, possiamo dire che
razionalità occidentale e modernità, cessano di agire all’unisono.
Lo
sradicamento dal luogo, vale a dire il fatto di non sentirsi più appartenenti
ad un territorio culturalmente e fisicamente definito, si intreccia alla
detemporalizzazione dell’esistenza quotidiana: come non ci si può più
riconoscere nella sofferta geografia dei nostri padri, così non si riesce più
a vivere l’esperienza del tempo come “presente”. Il presente è una sorta
di tempo compresso tra passato e futuro, tra ciò che sopravvive dell’epoca
dominata dalla mano e ciò che cade sotto il dominio della tecnica.
Il
critico d’arte Germano Celant, ha sostenuto la tesi di una totale
"inespressività" della nostra epoca: Il contemporaneo è una
presenza sfuggente in via d'estinzione. Le sue manifestazioni si svolgono sotto
i nostri occhi, senza che lo sguardo riesca a controllarle e a definirle o la
parola sia capace di descriverle in tempo, allo stesso tempo. Il suo scorrere rimane
tutto da scoprire, resta indefinito e informulato, esiste e si impone, ma non si
lascia incanalare. É difficile confinarlo in un paesaggio unico, rinchiuderlo
in un perimetro dove stabilire cosa passa e come succede. S’irradia
continuamente, liberandosi delle cose presenti. É un'energia a perdere, senza
limiti: tutto è identicamente contemporaneo, ma la definizione lo
smarrisce, ne attua la perdita (Germano Celant, Inespressionismo. L'arte
oltre il contemporaneo, Costa & Nolan, Genova 1988, p. 5).
Ma
è il fondamentale lavoro di autori come Hassan o Hardley a fare un punto
essenziale sulle caratteristiche del postmoderno.
Le
maggiori differenze che lo distinguono dalla modernità, chiamata
“modernismo” (assumendo il significato di un “ismo”, vale a dire di un
movimento culturale), sono riassunte da Harvey (David Harvey, La crisi
della modernità, 1993)
in una serie di cambiamenti, di cui i principali sono qui di seguito
elencati:
Modernismo
- Postmodernismo
romanticismo/simbolismo
--- patafisica/dadaismo
forma
(congiuntiva,chiusa) --- antiforma (disgiuntiva, aperta)
finalità
--- gioco
progetto
--- caso
gerarchia
--- anarchia
controllo/logos
--- finimento/silenzio
oggetto
d’arte/opera finita --- processo/performance/happening
distanza
--- partecipazione
creazione/totalizzazione/sintesi
--- decreazione/decostruzione/antitesi
presenza
--- assenza
concentrazione
--- dispersione
genere/confine
--- resto/intertesto
semantica
--- retorica
paradigma
--- sintagma
ipotassi
--- paratassi
metafora
--- metonimia
selezione
--- combinazione
radice/profondità
--- rizoma/superficie
interpretazione/lettura
--- controinterpretazione/fraintendimento
significato
--- significante
leggibile
--- scrivibile
narrazione/grande
histoire --- anti-narrazione/petite histoire
codice
principale --- idioletto
sintomo
--- desiderio
tipo
--- mutante
genitale/fallico
--- polimorfo/androgino
paranoia
--- schizofrenia
origine/causa
--- differenza-differenza/traccia
Dio
Padre --- Spirito Santo
Metafisica
--- ironia
determinatezza
--- indeterminatezza
trascendenza
--- immanenza
A
queste caratteristiche vanno aggiunte altre considerazioni. Il postmoderno vede
scomparire le contrapposizioni dialettiche più significative del moderno. Tra
queste la differenza semantica e concettuale tra interno ed esterno, tra visibile
ed invisibile, tra dicibile e indicibile; tra essenza ed apparenza, tra vero e
falso, tra realtà e simulazione; tra manifesto e rimosso; tra autentico e
inautentico, tra originale e imitazione,
tra unicità e copia, tra singolarità e serie; tra il significante e
significato.
Se
la paranoia dell’uomo moderno era determinata, come ci ricorda Harvey, nel suo
fondamentale saggio, dalla continua
frustrazione per il mancato raggiungimento di un futuro migliore, la
schizofrenia dell’uomo postmoderno è causata dalla frammentazione del
soggetto in una molteplicità di ruoli e di comportamenti, spesso inconciliabili
tra loro.
Non
più, dunque, blow-up, ingrandimento progressivo di un dettaglio, analisi
interminabile... come avrebbe detto Freud! Ma, cut-up, distruzione e
ricompattazione dei frammenti: blob.
Miliardi
di connessioni telematiche e televisive, come reti neuronali di un cervello
esteso come tutto il pianeta.
Solo
l’astuta cultura new age ha saputo
combinare armonicamente questi tempi, fondendo la nostalgia del preindustriale e
del primitivo con l’attrazione per i regni immateriali e simulativi della
tecnologia. Ed è soprattutto la musica new
age, attraverso l’adozione di discipline meditazionali, che non disdegnano
tuttavia i più significativi simboli della cultura
yuppistica, dalla BMW ai vini francesi all’elettronica acustica, a
rovesciare tutta la complessa e intrecciata esperienza musicale del jazz, della
classica e del rock in una dimensione che non vuole possedere più nulla di
sperimentale. Rilassante e rasserenante, la musica new
age si fa metafora di un’intera direzione dell’estetica, dell’arte e
della cultura, una direzione che vuole portare il soggetto ad una condizione di
totale abbandono nelle mani delle merci e della loro rappresentazione
pubblicitaria-ideologica.
Al
contrario di ciò che era stato e continua ad essere l’assunto fondamentale
dell’arte di tutte le avanguardie, la messa in discussione del mondo e, nello
stesso tempo, del soggetto, la
“nuova epoca” produce opere e comportamenti consensuali e consolatori.
La
schisi del soggetto postmoderno è dunque determinata dalla sua frammentazione,
dalla sua infinita duplicazione, come immediatamente hanno percepito e tradotto
in immagini inequivocabili gli artisti più “moderni” della postmodernità.
Tre
esempi significativi possono essere rappresentati da Gary Hill, Christian
Marclay, Cindy Sherman.



Gary
Hill (Inasmuch As it is Always Already
Taking Place, 1990, video installazione) colloca una ventina di monitors di
varie forme e misure, ognuno riproducente una porzione di un corpo umano,
all’interno di un loculo scavato nelle mura profonde del Martin Gropius Haus a
Berlino in occasione della mostra intitolata Metropolis
(International Art Exhibition Berlin 1991); Christian Marclay, nella dirompente
mostra, curata da Jeffrey Deitch e intitolata Post
Human (Lausanne, 1992; Torino-Rivoli 1992; Atene, 1993; Amburgo 1993),
accosta tra loro una serie di copertine di dischi (Christian Marclay, Doorsiana,
1991), ognuna riproducente un particolare del corpo umano, tentandone una
ricostruzione fittizia, in cui si armonizzano tra loro anche parti organiche di
sessi diversi; Cindy Sherman (Cindy Sherman, Untitled,
1992), nella stessa mostra, presenta delle grandi opere fotografiche, nelle
quali sono rappresentati dei manichini femminili, fatti a pezzi e rimontati in
maniera oscena.
Se prendiamo, tuttavia, in considerazione i fenomeni più recenti delle grandi mutazioni prodotte dalla tecnica nei vari campi, da quello dell’informazione, a quello della produzione simulativa, dall’ingegneria genetica alla clonazione, dalla cybernizzazione del mondo alla sua globalizzazione capitalistica, dobbiamo ammettere che lo stesso termine di postmoderno risulta già inefficace.